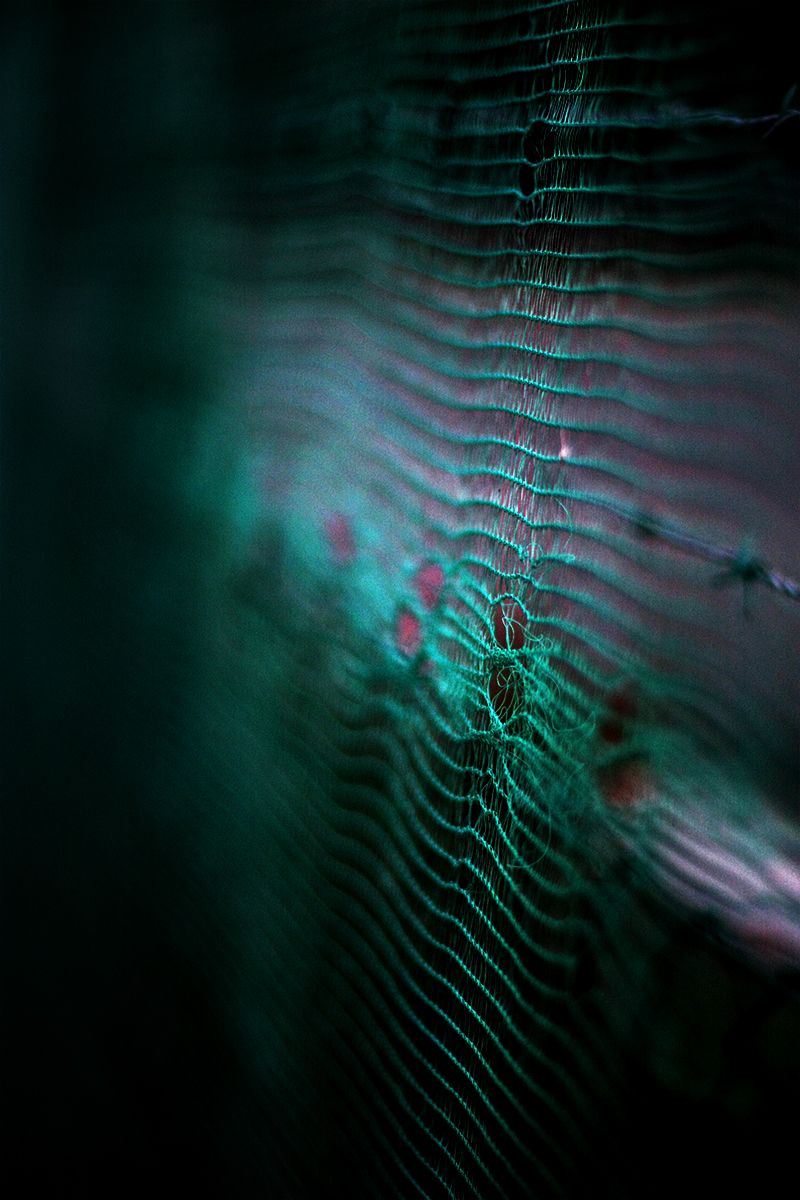Due voci e, in mezzo, lo stesso mare.
“DISPERARE [Dal latino desperare: composto dalla particella de, che denota allontanamento, e sperare, da spes, speranza]; Perdere la speranza; mancare di speranza”.
Te li immagini disperati. Mancanti di speranza.
“Non abbiamo bisogno che masse di disperati invadano il nostro paese”.
“È nostro dovere chinarci verso questa massa di disperati e concedere loro qualche forma di accoglienza”.
Due voci e, in mezzo, lo stesso mare.
Dal quale arrivano, a beneficio delle nostre paure o della nostra pietà, e dal quale partono.
Disperati? No. Così lontani dall’esserlo, da riuscire a gonfiarsi di speranza come vele, e salpare verso.
Verso il confine, verso la fine del deserto, verso un imbarco: verso. Verso l’Europa. Mai stata così bella, l’Europa, mai così meritevole di desiderio, quanto lo è nei loro occhi. Gente portatrice di una speranza tale da sovrastare il mare di umiliazione che la travolge. E che ce la restituisce intatta, sopravvissuta, vincente, quando arriva. Quelli che ce la fanno, che arrivano ai confini delle nostre acque territoriali e ai nostri porti.
A rigor di logica, dunque, è un’invasione di vincenti, quella di cui dovremmo parlare, se di invasione si trattasse; di speranti, quantomeno, e, certamente, di portatori di un vitalismo, di una vocazione alla salvezza e di una determinazione al successo che non possiamo negare.
Gente così vocata alla vita da non lasciarne intentato neanche un pezzetto.
Narrazioni.
Forse cambierebbe qualcosa se invece di immaginare barche di disperati, cominciassimo a immaginare barche di speranti, individui innegabilmente ottimisti, decisamente determinati e indubbiamente intraprendenti. E cambierebbe qualcosa, se ci accorgessimo che coloro che immaginiamo esauriti dalla categoria della privazione, sono, al contrario, oggetto di un investimento (affettivo, economico e motivazionale) ingente, un investimento che talvolta trascende i limiti della famiglia per estendersi a quelli della comunità di appartenenza.
Forse cambierebbe qualcosa se ce li immaginassimo partire pieni (di speranza) e ricchi (di motivazione individuale e di sostegno collettivo), invece che vuoti e poveri, gente pronta a investire energie preziose nel paese di approdo, invece che vasi vuoti da riempire.
Narrazioni.
Disperati, poveri, portatori di malattie o Ricchi, determinati, resilienti?
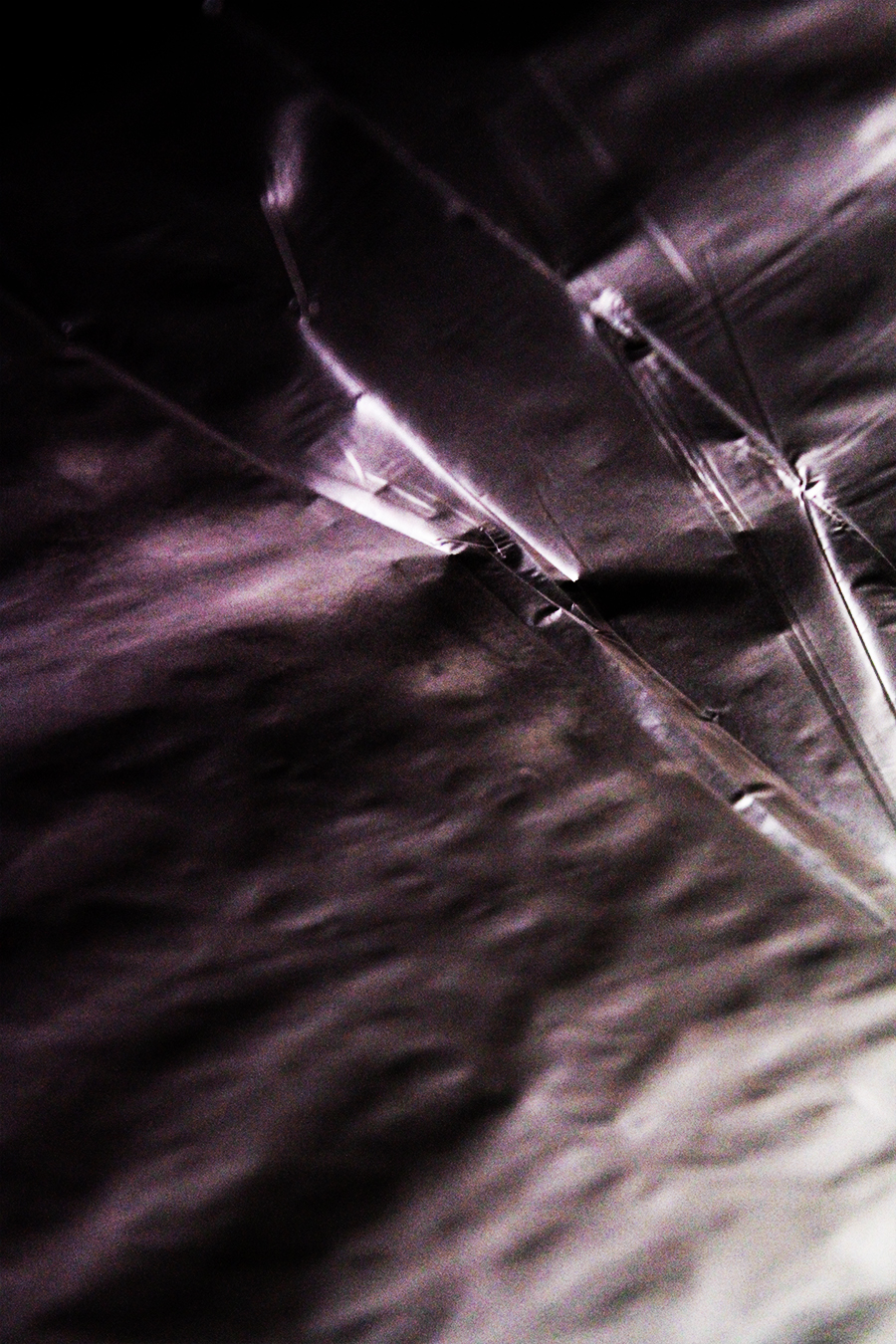
Fernanda Pietrarelli “DDO”
Chi scrive non ritiene che vi sia una versione vera e un’altra falsa, ma semplicemente che utilizzare l’una, piuttosto che l’altra, sia una scelta narrativa che incide direttamente sulla realtà: la scelta narrativa diventa, dunque, un atto politico.
Assodato ciò, si tratta di capire quanto le narrazioni incidano sulle politiche e quanto, invece, siano le politiche a plasmare narrazioni. Vasi comunicanti, una perfetta sinergia. Si tratta di capire che la pregnante relazione tra questi due enti non è affatto anodina o accidentale, ma è piuttosto il nodo di giunzione tra chi siamo e chi vogliamo essere o, se vogliamo, il perno attorno al quale può girare la cinghia di trasmissione del nostro divenire.
Immaginario, narrazione e linguaggio, infatti, sono diventati attori politici di primo piano e non solo quando si tratti di “politiké” nella sua accezione più estesa.
Si pensi, ad esempio, a quella “svolta narrativa” che ha preso piede in Italia a metà degli anni ’90 e che ha tolto definitivamente ai partiti e alle organizzazioni (ai sindacati, alle associazioni) il primato sulla formazione dell’opinione e delle coscienze, per consegnarlo ai carismi individuali dei leader, alla loro forza persuasiva, alla loro abilità retorica, alla loro capacità di raccontare sé stessi e di rappresentare gli altri.
Come raccontiamo noi stessi e gli altri, a quali narrazioni crediamo e quali riproduciamo, quindi, sono azioni che devono definitivamente essere derubricate dal campo dell’immaginifico o del privato.
Nel 2016, anche l’Associazione Italiana di Studi Semiotici decide di azzardare un passo fuori dai suoi consueti territori di indagine e di dedicare il suo 44° congresso annuale al “controverso rapporto” tra narrazione e realtà. Sottotitolo: Il senso degli eventi. Affrontare questo tema le è parso improcrastinabile: “La questione è tanto più rilevante nel momento attuale, poiché da sempre più numerosi punti di vista si parla di narrazioni che determinano la vittoria dei politici, il destino delle imprese economiche e che definiscono il modo in cui tutti concepiscono la propria esperienza di vita”.
Dunque, è proprio vero: “cambia qualcosa”, nella realtà, quando cambiano i linguaggi e il racconto con cui la si rappresenta.
E, a proposito di rappresentazioni, persino la cartografia ha raccolto la sfida della postmodernità per superare definitivamente la definizione di mappa come strumento oggettivo e scientifico di rappresentazione del reale.

Fernanda Pietrarelli “DDO”
La cartografia come strumento narrativo
Perfino la cartografia, che comincia a proporsi come “post-rappresentativa”, o addirittura “riflessiva” (si seguano i lavori della geografa e teorica della cartografia Emanuela Casti), si riconosce anche come strumento narrativo o, meglio, come strumento comunicativo in grado di intervenire sulla conoscenza e sulla percezione del mondo.
Un interessante seminario del DIATI (Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture) del Politecnico di Torino, dedicato al tema della rappresentazione cartografica, tenutosi nel 2019 e che ha scelto di ospitare una mia Lezione recitata sul tema del confine, recava, appunto, il titolo “Le mappe della disperazione”.
La mente corre veloce ai flussi di uomini e donne che disegnano rotte attraverso i continenti, che compongono la mappa, con i loro passi, con le loro soste forzate, con le sterminate fosse comuni in cui riposano, del mondo che questo genere di capitalismo ha prodotto. Come dare una rappresentazione di quelle mappe? Con quali strumenti, rendere conto della complessità di quel fenomeno? Ma, soprattutto, come non ammettere che qualsiasi esito ne risultasse, si tratterebbe, comunque, di una mappa culturalmente determinata e, in taluni casi, ideologicamente connotata?
Ancora una volta, sarebbe ben più di “qualcosa” a cambiare, a seconda della rappresentazione che si scegliesse di dare a questo fenomeno.
Facciamo qualche esempio: immaginiamo che le rotte migratorie a cui stiamo facendo riferimento vengano rappresentate con delle linee nere che vanno dal punto di origine dei loro protagonisti alla loro destinazione effettiva. E immaginiamo che quelle linee vengano tracciate su una classica “cartina fisica” dei continenti africano ed europeo, con i loro fiumi, laghi, deserti, aree in verde, rilievi principali, ecc… In questo caso, il lettore della mappa ha la possibilità di associare le linee nere (le rotte) alle condizioni di carattere fisico e naturale rappresentate sotto di esse e sarà portato a stabilire nessi di causalità con quegli indicatori (dal clima alla ricchezza o meno d’acqua, alla prossimità delle risorse, alla pluviometria, ecc..).
Se, putacaso, quelle linee venissero invece sovrapposte alle care e vecchie “cartine politiche” (quelle neutrali raffigurazioni del mondo in cui vengono riportate le linee di confine tra gli stati, le città con il loro numero di abitanti e via di seguito), allora, in questo caso, potrebbe agevolmente venire in mente qualche ipotesi sul legame, ad esempio, con la popolosità dei luoghi di partenza, con l’isolamento o meno rispetto alle grandi rotte commerciali o vie di comunicazione, ecc…

Fernanda Pietrarelli “DDO”
Rappresentazione, percezione e interpretazione
Avendo ormai compreso, al di là delle semplificazioni offerte da questi esempi, la pregnanza, la ricchezza di implicazioni e la problematicità dei legami tra rappresentazione, percezione e interpretazione – verrebbe da dire del nesso tra mappa e storia -, siamo ora in grado di intendere il gesto del disegnare una mappa come un esercizio di potere e, al tempo stesso, come l’espressione di un particolare sistema di potere e possiamo osservare quel gesto con uno sguardo pieno di interrogativi: che storia decide o ha deciso chi disegna una mappa?
L’eclatante caso della mappa del Medio Oriente mostrata da Netanyahu durante il suo discorso alla 78° sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel settembre 2023, ce lo mostra in modo così esplicito da rischiare di farci perdere di vista il nostro ragionamento, che è più sottile e mira a decostruire le complesse narrazioni implicite, spesso involontarie, sottese alle rappresentazioni cartografiche. In questo caso, invece, il politico israeliano ci offre, banalmente, una semplice “grafica degli intenti”, l’esplicita rappresentazione cartografica di un progetto di eliminazione di un Paese (e del suo popolo): in quella cartina, la Palestina non è rappresentata, tout court. Al suo posto, si estende lo Stato di Israele, in un unico colore blu.
Ritorniamo, quindi, al precedente ragionamento sulla rappresentazione cartografica dei flussi migratori, alle cartine fisiche, alle cartine politiche, alle mappe tematiche su cui potremmo disegnarli e chiediamoci: cambierebbe qualcosa se, in luogo delle caratteristiche fisiche del continente africano, il cartografo utilizzasse simboli e variazioni di tonalità per indicare le percentuali di terre “grabbate”, o se in luogo delle capitali, il cartografo indicasse – magari anche con una bandierina che specifichi la nazionalità dei proprietari o dei concessionari – i principali siti minerari o i principali giacimenti petroliferi?
E cambierebbe qualcosa, nella nostra percezione del fenomeno, se invece delle indicazioni altimetriche, tanto per dire, i numeri sulla mappa indicassero le tonnellate di materia prima prodotte in un anno in una determinata regione, la percentuale trasformata nella regione stessa e, sempre nella stessa regione, il numero di persone morte per fame ogni anno? E, infine, cambierebbe parecchio se, al posto di quei numeri, il cartografo scegliesse invece di indicare, tanto per fare un esempio, la stabilità politica e l’ingerenza straniera, il tasso di delinquenza, il numero di aggressioni, di furti o di stupri all’anno.
Le linee delle rotte di migrazione, assumerebbero significati completamente diversi e la gente che su quelle rotte si muove sarebbe oggetto di una percezione profondamente diversa.
Narrazioni.
Senza accontentarci di così immediate esemplificazioni, è chiaro che la mappa deve essere letta, anzitutto, come “un campo semiotico autoreferenziale” – per citare ancora la professoressa Casti – il cui valore prevalente è quello simbolico e comunicativo: uno strumento, in altre parole, per tradurre in segni la realtà percepita e, per altro verso, per implementare la percezione della realtà.
Diventa d’obbligo, a questo punto, interrogarsi sulla questione delle questioni. Ma se non possiamo più fare affidamento su una narrazione (e persino su una mappa) che fotografi il reale in modo oggettivo ed esaustivo, cioè su una narrazione (o una mappa) che sia vera in contrapposizione con tutte le altre, che diventerebbero, di conseguenza, false (o parziali, nella migliore delle ipotesi), e se, come abbiamo detto, le nostre narrazioni informano in modo diretto la realtà, allora quale diventa lo statuto epistemologico delle nostre credenze?
Insomma, prima si suggerisce che considerare i migranti dei disperati invece che dei vincenti incide profondamente sul loro destino (e sul nostro) e che quindi bisogna fare ben attenzione al linguaggio che si usa e alla narrazione a cui si sceglie di aderire, poi si aggiunge che, però, questi migranti sono tanto disperati quanto vincenti e che non c’è un racconto vero e uno falso (in questo caso)… ma allora capiamoci: come dobbiamo chiamarli, questi migranti?

Fernanda Pietrarelli “DDO”
Chi siamo e cosa vogliamo essere
Già, ma… come vogliamo? Come li vogliamo e ci vogliamo? Il problema è proprio qui: chi siamo e cosa vogliamo essere.
Come dobbiamo chiamarli? La risposta è esattamente questa: in base a chi siamo e a cosa vogliamo essere. Cosa vogliamo farne di noi, e di loro? Quale idea di umanità alberga nelle nostre credenze e quale futuro desideriamo realizzare?
Una volta data una risposta a questa domanda e fatte salve alcune osservazioni storico-sociologiche inconfutabili sulla questione (dalla depredazione delle risorse nei paesi loro, all’impoverimento dei paesi nostri, dall’inalienabilità dei diritti umani loro, alla sofferenza di certe periferie nostre), non resta che scegliere le narrazioni più funzionali a corrispondere a quell’idea. E realizzare quel futuro.
La filosofa Rosi Bardotti parla di quel terribile “facciamo cosa vogliamo” in termini più complicati, ma affascinanti, parla del desiderio quale motore del divenire storico: il desiderio è “la disposizione materiale e socialmente approvata delle condizioni che permettono l’attuazione (cioè la realizzazione immanente) della modalità affermativa del divenire” (In metamorfosi. Verso una teoria materialistica del divenire, 2003).
Non a caso – visto che di genti in movimento stiamo parlando -, Bardotti immagina una dimensione etica e politica che definisce “nomadismo filosofico”, un progetto che “si concentra sul divenire o sulle trasformazioni, proponendo una filosofia pragmatica che sottolinea la necessità di agire, di sperimentare nuovi modi di costituire la soggettività e di relazionarsi all’alterità” (Trasposizioni. Sull’etica nomade, 2008)
A noi, dunque, il compito di guardare nelle nostre mappe e di scegliere cosa volere.
«La sola cosa che possiamo tentare di fare è di influenzare la direzione che stiamo prendendo. Dato che presto potremmo essere in grado di progettare anche i nostri desideri, forse la vera questione che ci troviamo di fronte non è “Cosa vogliamo diventare?” ma “Cosa vogliamo volere?”. Coloro che non sono spaventati da questo interrogativo, probabilmente non ci hanno riflettuto abbastanza».
Lo scrive Yuval Noah Harari (Da animali a Dei. Breve storia dell’umanità, 2014), fiancheggiatore di una svolta transumanista che consegnerà ad altri decisori, posti al di fuori della coscienza individuale e della dialettica collettiva, molte prerogative dell’umano, persino quella di “progettare anche i nostri desideri”.
Coloro che non siano spaventati da questa nuova mappa dell’umano, ammette, non ci stanno riflettendo abbastanza: siamo perfettamente d’accordo con lui.
Fortunatamente, antiche mappe disegnarono con altra sapienza l’incessante risacca tra l’umano e il divino, e anche in quelle mappe ci possiamo guardare de-siderando il nostro futuro: “O Adamo, non ti abbiamo dato una sede determinata, né una figura tua propria, né alcun dono peculiare, affinché quella sede, quella figura, quei doni che tu stesso sceglierai, tu li possegga come tuoi propri, secondo il tuo desiderio e la tua volontà. […] Tu, che non sei racchiuso entro alcun limite, stabilirai la tua natura in base al tuo arbitrio, nelle cui mani ti ho consegnato. O somma liberalità di Dio Padre, somma e mirabile felicità dell’uomo! Al quale è dato avere ciò che desidera, essere ciò che vuole. Chi non ammirerà questo nostro camaleonte?”. (Pico della Mirandola, Discorso sulla dignità dell’uomo, 1486).